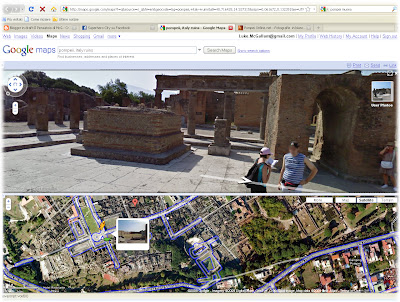Fa freddo.
Da quassù si intravvede un cielo colore di piombo e intanto la città è avvolta nel silenzio da una coperta di bruma.
Poche luci qua e là, qualche lampione, pochi suoni ovattati.
Una macchina parcheggiata all'angolo emette un denso fumo nero, mentre, all'interno il proprietario stringe nervosamente una sigaretta tra i denti, spenta e, con dita ingiallite, sfoglia distrattamente il giornale appena acquistato all'edicola del corso.
Non ha fretta, ma è come se ne avesse, nonostante l'alba tardi ad arrivare; nonostante l'orologio del campanile abbia appena smesso di suonare le sei.
Un rapido movimento del piede sull'acceleratore e lo sbuffo di fumo si fa più denso, il rumore del motore più cavernoso. Se non fosse che sono quassù, troppo distante, direi che nell'aria c'è odore di gasolio.
Forse sono solo i camini di troppo vecchie caldaie.
Un gatto da sotto l'auto, probabilmente acquattato in cerca di calore, schizza spaventato e attraversa la strada lanciando un miagolio lancinante.

Fortuna vuole nessuno passi per le strade.
D'improvviso si spalanca una finestra facendo filtrare verso l'esterno la luce aranciata di una lampadina ad incandescenza, ancora appesa al soffitto per i soli cavi, senza un lampadario che la contenga. Un donna si affaccia, appoggia un cuscino sul davanzale e lo percuote facendo uscire sbuffi di polvere che presto si confondono nella nebbia.
Il rumore rimbomba per il quartiere ancora addormentato, sordo e fastidioso.
Un altra finestra si apre di fronte, ne esce un uomo che inveisce volgarmente, quindi senza attendere risposta richiude le persiane sbattendole.
Intanto, un sole malato albeggia chissà dove sull'orizzonte, schiarendo l'aria livida senza che nulla prenda colore.
Non mi piace questa città, non mi piace questa gente. Anche là, sulla panchina, con la vita appesa agli aghi di ghiaccio di una notte troppo fredda, coperto di brina e pochi cartoni, un barbone attende dormendo che un altro minuto passi. E poi un altro e un altro ancora, aspettando che un Godot qualsiasi arrivi per dare un senso al tutto.

Ma pare che il senso sia già lì, da lunghi anni, nelle forme di un albero senza foglie, bruna corteccia nella bruma.
Poi, un refolo venuto da chissà dove, straniero nella calma surreale, mi scuote e volgo lo sguardo altrove, oltre il velo leggero di un vetro appannato, dietro il quale una donna è intenta a cercare, con una spazzola e pochi trucchi, di ritrovare una bellezza forse mai avuta.
Odo le rughe, la cui profondità da lungi non posso che immaginare, raccontare le mille storie di una donna, le verità vere e quelle immaginate, le sento, come dai solchi di un vinile, cantare ricordi di amori che l'hanno vissuta, usata e alla fine consumata.
Nella finestra accanto, come uno scherzo del destino, una giovane, poco più che bambina, è già desta, con lo sguardo vivace immerso in un libro di parole stampate e di un nome scritto ripetitivamente sul lato. Il nome di un giovane che non la noterà mai. Troppo acerba, ancora, e lui troppo stupido per leggere nella pallida luce dell'albore, il fulgore dorato del meriggio.

Più in là un cancello automatico sia apre accompagnato dal mesto ronzio del motore elettrico, presto sovrastato dallo stridio di gomme che mordono il cemento dal buio di una rimessa sotterranea.
Pochi passeri intirizziti dal freddo s'alzano in un volo in cerca di un luogo più sicuro mentre la vecchia automobile, gialla, schizza fuori dal passo carraio. L'uomo che la guida suda di una paura ancestrale.
Accanto a lui una donna dai capelli unti stringe tra i denti il proprio dolore.
Fanno solo pochi metri e il semaforo, fino ad allora lampeggiante si colora di rosso.
L'utilitaria frena, poi attende impaziente rombando come se ferma ad uno starter.
La donna china la testa, poi la protende all'indietro, quasi prevenendo l'accelerazione che segue al suono del clacson.
Un accelerazione breve perché da sinistra sbuca un furgoncino.
A guidarlo c'è un uomo di mezza eta, barba sfatta, guance coperte da un intricato complesso di capillari bruciate da sole e intemperie. Gli occhi sono rossi, lo sguardo vitreo, forse a causa del sonno, forse a causa di una colazione a base di vino.
Sta canticchiando una vecchia canzone di Battisti, quando i due mezzi impattano.
Lo scontro è forte, il rumore delle lamiere che si accartocciano ha un qualcosa di sinistro.
In un attimo tutte le finestre che danno sull'incrocio si aprono, c'è chi esclama, chi evoca santi e madonne.

Qualcuno chiama l'ambulanza, qualcuno scende velocemente, chi per curiosare, chi per soccorrere.
Io osservo.
Ho un senso malessere, sarei libero di andarmene ma qualcosa mi lega a questo posto.
Pare che per l'uomo alla guida del furgoncino non ci sia nulla da fare.
L'uomo dell'utilitaria si trascina a terra, probabilmente ha le gambe spezzate, il volto coperto di sangue tradisce ferite che pulite si riveleranno lievi.
La donna a terra, dall'altra parte, urla di dolore comprimendosi il ventre.
Il mio malessere aumenta ogni secondo che passa. Mi sento come costretto, anche se qualcosa mi dice che sta per arrivare il momento in cui potrò andarmene.
La nebbia si dirada, ritirandosi lentamente nei prati del parco, da lontano si ode il suono di una sirena, da vicino le urla di quella donna.
L'ambulanza arriva, seguita da un'altra e da un'altra ancora.
Il mio momento è infine arrivato.
Devo andare.
Devo nascere.
Appunti di Viaggio
Scrissi questo racconto breve, circa diciotto anni fa durante un noiosissimo servizio di guardia (medica) presso una Polveriera, durante il servizio militare. A differenza della “Guardia” vera e propria, l’Assistente di Sanità doveva semplicemente presidiare il locale adibito ad infermeria nella speranza che nessuno stesse male o, peggio, si facesse male. Per una settimana.
Il racconto soffre quindi della cupa atmosfera del posto, nonché della giovane età in cui lo scrissi.
Rileggendolo ora mi accorgo che l'osservatore-anima avrebbe forse dovuto rimanere più asettico, più distaccato. L'idea però mi piace ancora e, non avendo tempo di rielaborarlo, ho deciso di pubblicarlo così come fu scritto.